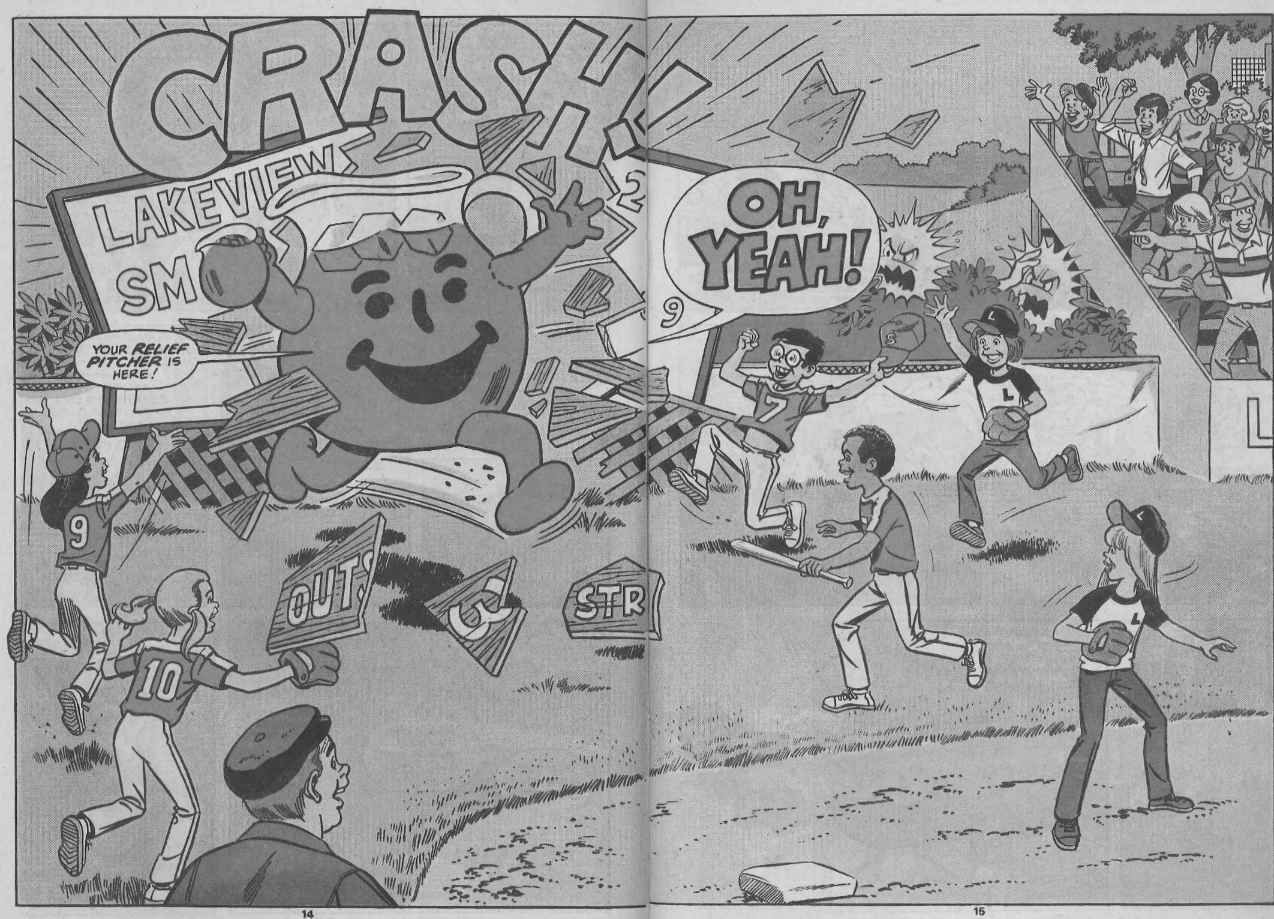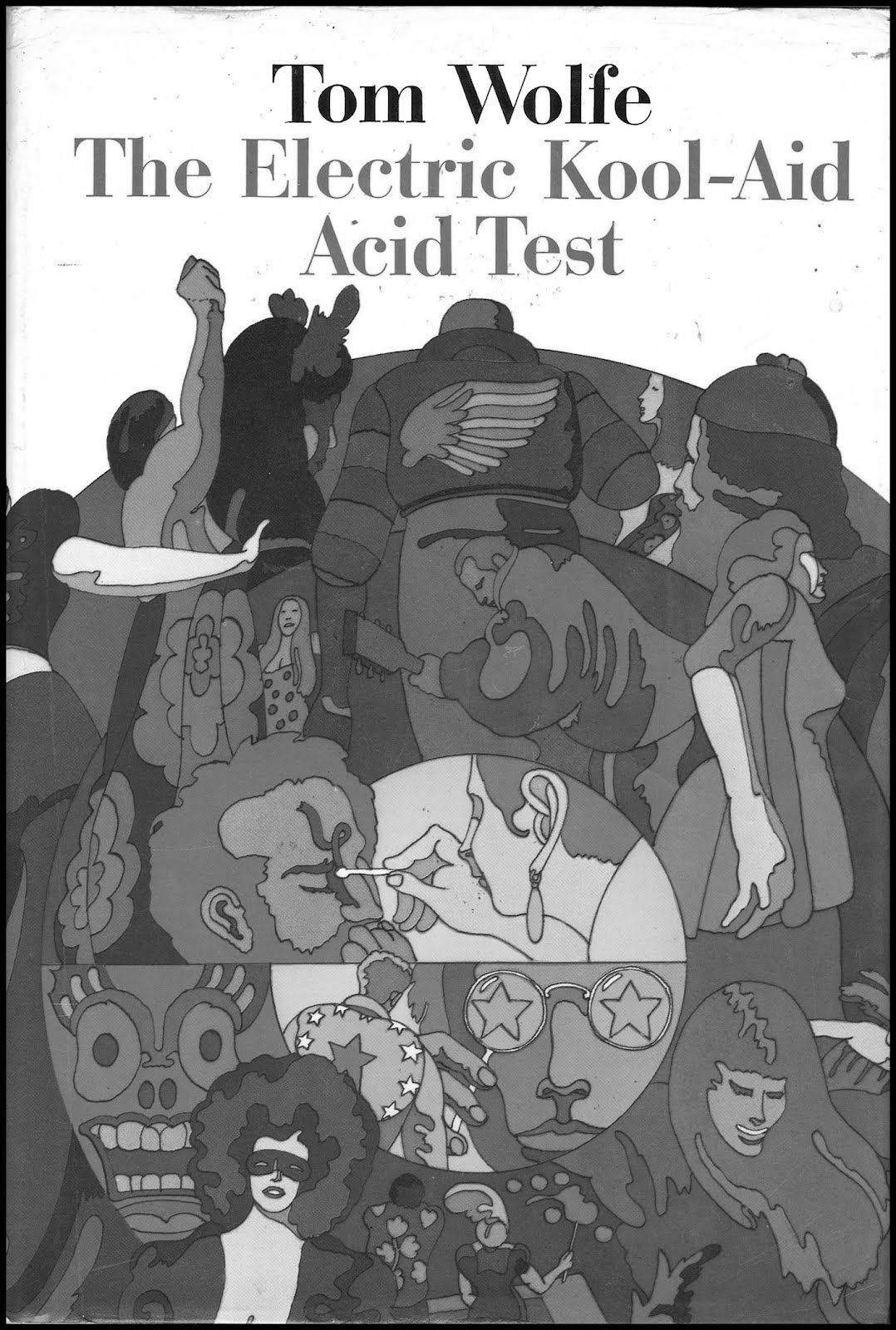Io fui di una sostanza condannata a esistere
Io fui di una sostanza rassegnata a rivivere
Io fui di una sostanza rassegnata a riscrivere
Lo stesso codice
Per altra mano
Bachi da Pietra – “Seme Nero”
Cos’è True Detective?
Una gara tra due attori su chi è il più bravo. È fin troppo facile dire che il migliore è Matthew McConaughey-Rust, con lo sguardo allucinato di uno che ha guardato troppo dall’altra parte, per scoprire che non c’è altra parte e tutto è qui, in questo mondo, e dietro il velo non c’è niente.
Una decostruzione del tipico film sulla coppia di poliziotti. Woody Harrelson-Marty è immenso. con la sua bocca all’ingiù e lo sguardo di un uomo che sta sempre sul punto di esplodere. Tra i due, è forse quello che va incontro alla disillusione più dolorosa, quella dell’umano troppo umano e dei valori terreni che si sfasciano, perché a un certo punto tra un uomo e una donna, come viene detto, si mette di mezzo la verità.  Una storia sul male del detective, che è sempre il vedere troppo o troppo poco. Ed ecco che Rust è quello che ha guardato troppo e anzi, addirittura, soprattutto nella prima puntata, è quello che guarda e disegna, che guarda disegnando sul suo taccuino, riporta la posa delle vittime, il palco che incorona la testa e lo strano disegno a spirale. E Marty quello che vede troppo poco, colui che pecca sempre di disattenzione, che si lascia andare a reazioni eccessive e proprio per questo, ancora una volta, umane.
Una storia sul male del detective, che è sempre il vedere troppo o troppo poco. Ed ecco che Rust è quello che ha guardato troppo e anzi, addirittura, soprattutto nella prima puntata, è quello che guarda e disegna, che guarda disegnando sul suo taccuino, riporta la posa delle vittime, il palco che incorona la testa e lo strano disegno a spirale. E Marty quello che vede troppo poco, colui che pecca sempre di disattenzione, che si lascia andare a reazioni eccessive e proprio per questo, ancora una volta, umane.
Un oggetto pop perfetto, la serie più potente, dai tempi di Twin Peaks, nello spingere i fan a cercare indizi, significati, sensi nascosti. Al punto che in rete ci sono fermi immagine, ingrandimenti, interpretazioni allucinate delle allucinazioni visive. I simboli sono comparati, i riferimenti sviscerati, le ipotesi portate al punto di implosione. Proliferano scenari di complotto e letture filosofiche. Gli archetipi junghiani vengono accostati a Nietzsche, la New Orleans popolata da white trash a piccole costruzioni di legno che rimandano a leggende voodoo.
Una serie portale. Con un sacco di ingressi e di uscite che portano a classici della Weird Fiction come Il Re in Giallo (con la misteriosa città di Carcosa), ma anche alla provincia nera alla Lynch, oppure ai libri del post nichilismo contemporaneo, con intere frasi di The Conspiracy Against the Human Race di Thomas Ligotti prese di peso per il memorabile dialogo in macchina tra i due protagonisti [l’omaggio è riconosciuto apertamente dall’autore Nic Pizzolatto in un’intervista ed esiste perfino una bibliografia consigliata – non ufficiale – che accompagna la visione].
Una serie fatta di apparizioni e visioni fugaci. La tenda del predicatore revivalista con frammenti di umanità derelitta; l’allucinante immagine finale della terza puntata, con il meth cooker tatuato che cammina con una maschera antigas in mezzo alla jungla del bayou, apparizione degna dell’arrivo di Willard alla base di Kurtz, in Apocalypse Now. Solo per fare qualche esempio.  E quindi una storia che porta al cuore di tenebra, ovviamente, in una città che sembra fatta solo di zone di conflitto, paludi, apparizioni di torri industriali (che sia quella la spettrale città di Carcosa?), bordelli in roulotte e ritrovi di bande biker. Per non parlare del cadavere da cui inizia tutto, adagiato sotto un albero che è troppo fuori posto e incongruo per non essere oscenamente simbolico, nella pianura assoluta della Louisiana.
E quindi una storia che porta al cuore di tenebra, ovviamente, in una città che sembra fatta solo di zone di conflitto, paludi, apparizioni di torri industriali (che sia quella la spettrale città di Carcosa?), bordelli in roulotte e ritrovi di bande biker. Per non parlare del cadavere da cui inizia tutto, adagiato sotto un albero che è troppo fuori posto e incongruo per non essere oscenamente simbolico, nella pianura assoluta della Louisiana.
Ed è, secondo me, anche una strana serie “padana”, che ricorda gli horror in pieno sole di Pupi Avati o le misteriose evocazioni fantasmatiche di certi film di Bertolucci (e, infatti, al Fiction Fest Carlo Freccero ha avuto l’intuizione geniale di accostare a True Detective La Strategia del Ragno, un altra storia sul senso di colpa e sull’impossibilità di liberarsi del passato). L’orizzonte della Lousiana diventa uno sfondo illusionistico, un fondale teatrale su cui gli sguardi dei protagonisti si posano senza riuscire a trovare un senso dietro il semplice posarsi della luce sull’erba o sull’acqua, come in certe immagini di Luigi Ghirri.
True Detective è sicuramente una serie per cinefili, elogiata dallo stesso Bertolucci; divorata fino all’indigestione da Paul Schrader: al regista di American Gigolo (e sceneggiatore di Taxi Driver) il finale però non è piaciuto, ed è logico, essendo una storia nichilista che sembra un omaggio al cineasta religioso per eccellenza. E True Detective è fin troppo didascalico nel suo pessimismo, almeno quanto era didascalico il capolavoro assoluto di Schrader, Hardcore, con i suoi calvinisti olandesi messi alla prova dal vento capriccioso della grazia.
Altre cose che si vedono: un piano sequenza straordinario, con la cinepresa che non si stacca mai da Rust in una sparatoria nella suburbia della guerra tra bande di spacciatori; una palude che sembra Vietnam, appunto, (e il Vietnam viene citato a più riprese, in effetti, e fa pensare ancora ad Apocalypse Now), ma anche un ricordo del grande I Guerrieri della Palude Silenziosa di Walter Hill. E ci sono, ancora, echi dei giochi di prestigio dei Soliti Sospetti, in cui tutto viene messo in moto da un interrogatorio e quello che si racconta non è ciò che si vede. E poi potrebbe essere un dramma da interni in cui i conflitti familiari vengono descritti in modo non consolatorio, ed è bravissima anche Michelle Monaghan-Maggie,che contribuisce a spingere la vicenda verso i disastri inevitabili.  Mentre scrivo (senza ancora aver visto la fine), True Detective mi pare un enorme remake della Promessa di Dürrenmatt, cioè la storia di un uomo che non riesce a liberarsi di un caso del passato e la cui vita si popola dei fantasmi delle vittime e di un colpevole mai catturato. Ecco allora che True Detective è un requiem per il romanzo giallo; un gotico sudista in cui proliferano simbolismi misteriosi; un giallo paranoico e occultista, pieno di trabocchetti e false piste messe; un racconto di Lansdale con la filosofia al posto delle scazzottate; un David Lynch con più spiegazioni e l’idea che da qualche parte esista una forma di verità, per quanto confusa; un oggetto fatto apposta per generare culti appassionati ed esercizi ermeneutici (ci sono già delle guide per decifrare i simboli contenuti nei disegni tatuati sul corpo di alcuni dei personaggi…).
Mentre scrivo (senza ancora aver visto la fine), True Detective mi pare un enorme remake della Promessa di Dürrenmatt, cioè la storia di un uomo che non riesce a liberarsi di un caso del passato e la cui vita si popola dei fantasmi delle vittime e di un colpevole mai catturato. Ecco allora che True Detective è un requiem per il romanzo giallo; un gotico sudista in cui proliferano simbolismi misteriosi; un giallo paranoico e occultista, pieno di trabocchetti e false piste messe; un racconto di Lansdale con la filosofia al posto delle scazzottate; un David Lynch con più spiegazioni e l’idea che da qualche parte esista una forma di verità, per quanto confusa; un oggetto fatto apposta per generare culti appassionati ed esercizi ermeneutici (ci sono già delle guide per decifrare i simboli contenuti nei disegni tatuati sul corpo di alcuni dei personaggi…).
A proposito, il Re in Giallo è un dramma teatrale che fa impazzire chiunque lo legga. Un’opera che non esiste se non attraverso le citazioni e le allusioni contenute nei racconti della raccolta omonima di R.W. Chambers. Particelle di senso che girano attorno al vuoto. E tutto si avvolge tornando al punto di partenza. Dürrenmatt in salsa weird che formula ipotesi di fisica quantistica nella palude della Louisiana. E Nietzsche, col corpo coperto dai tatuaggi da G.G. Allin, che cuoce metanfetamine pensando all’eterno ritorno.


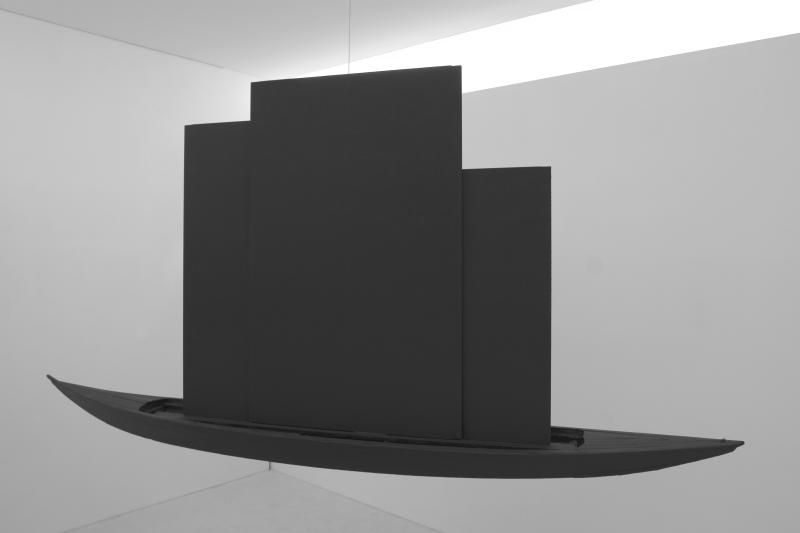
 Una storia sul male del detective, che è sempre il vedere troppo o troppo poco. Ed ecco che Rust è quello che ha guardato troppo e anzi, addirittura, soprattutto nella prima puntata, è quello che guarda e disegna, che guarda disegnando sul suo taccuino, riporta la posa delle vittime, il palco che incorona la testa e lo strano disegno a spirale. E Marty quello che vede troppo poco, colui che pecca sempre di disattenzione, che si lascia andare a reazioni eccessive e proprio per questo, ancora una volta, umane.
Una storia sul male del detective, che è sempre il vedere troppo o troppo poco. Ed ecco che Rust è quello che ha guardato troppo e anzi, addirittura, soprattutto nella prima puntata, è quello che guarda e disegna, che guarda disegnando sul suo taccuino, riporta la posa delle vittime, il palco che incorona la testa e lo strano disegno a spirale. E Marty quello che vede troppo poco, colui che pecca sempre di disattenzione, che si lascia andare a reazioni eccessive e proprio per questo, ancora una volta, umane.