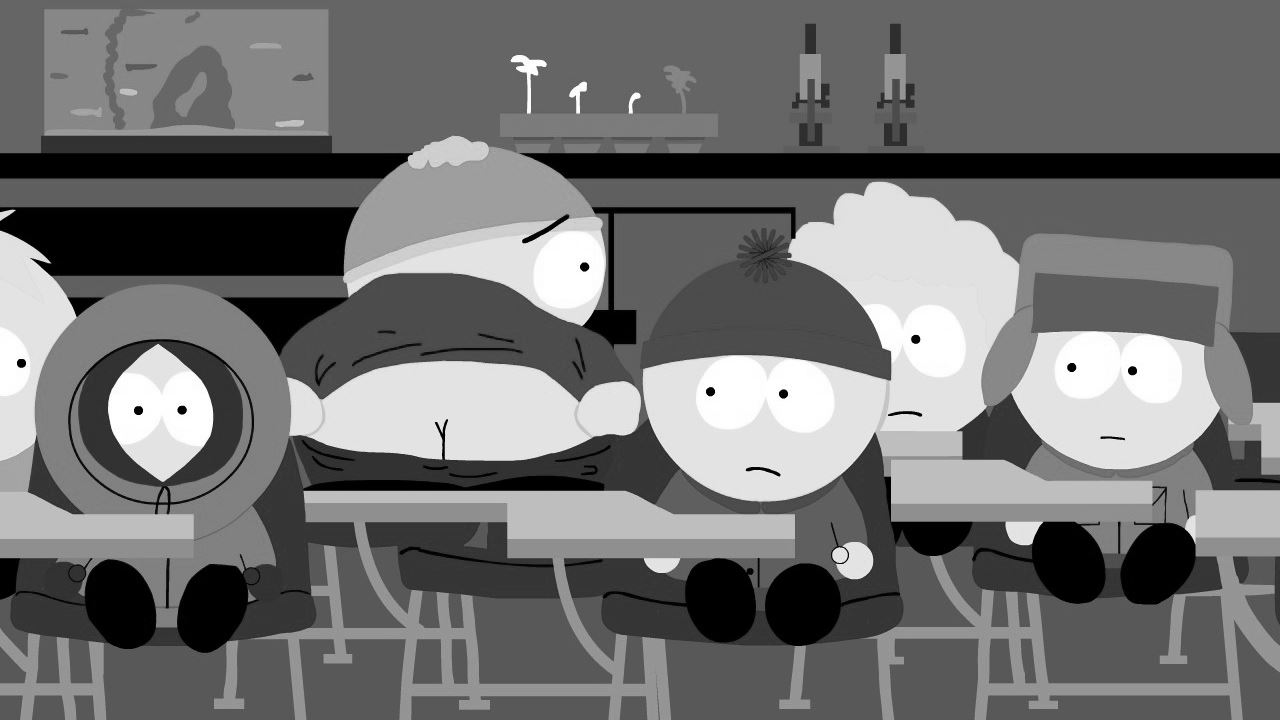Prima di riprendere a raccontare dei concerti visti in questo scorcio d’estate mi concedo una digressione su due interessanti documentari visibili interamente su Youtube, entrambi riguardanti il tema dei festival estivi di musica rock. Il primo, Festivals Britannia, è un documentario inglese del 2010 realizzato dalla BBC e racconta l’origine e lo sviluppo del fenomeno festivaliero nel Regno Unito. A dare ascolto al documentario, gli inglesi con l’approssimarsi dei mesi più caldi dell’anno subiscono una sorta di richiamo ancestrale che li porta nella campagna circostante le loro città e li invita a dare sfogo ai più reconditi istinti di libertà e promiscuità, possibilmente in vicinanza di qualche dolmen od altri ameni luoghi druidici.
 Questi sentimenti, a cui in breve tempo si aggiunse il desiderio di ballare a ritmo di musiche più moderne rispetto alle melodie barocche di Purcell o alle marce per bande di J. P. Sousa, erano per lo più prerogativa di una precisa porzione della società inglese, quella dei giovani cittadini nati durante le ristrettezze del dopoguerra. I componenti di questo nuovo gruppo sociale improvvisamente decidono di avere bisogno del proprio spazio, fisico e mentale, e per i pochi giorni d’estate dei festival tagliano letteralmente i collegamenti con la loro vita abituale. Negli anni ’60 e sino ai primi anni ’90 i festival si trasformarono in eventi giganteschi, che potevano fruttare un bel malloppo in pochi giorni ma che spesso venivano organizzati in maniera follemente dilettantesca. Venivano percepiti come una sorta di bolla in cui senso di libertà e musica la facevano da padrone anche se non mancava la possibilità di godere marginalmente di sesso, alcol, droga, un po’ di violenza gratuita e fango, tanto fango. Nel corso degli anni ’90 il fenomeno si normalizzò, il senso di anarchia si stemperò fino a sparire lasciando più spazio ai soldi e al main stream. Fu come se ai festival fosse stato applicato lo stesso trattamento destinato, durante gli stessi anni, al tifo inglese negli stadi, anche se attraverso modalità meno dirette (e repressive) da parte del governo.
Questi sentimenti, a cui in breve tempo si aggiunse il desiderio di ballare a ritmo di musiche più moderne rispetto alle melodie barocche di Purcell o alle marce per bande di J. P. Sousa, erano per lo più prerogativa di una precisa porzione della società inglese, quella dei giovani cittadini nati durante le ristrettezze del dopoguerra. I componenti di questo nuovo gruppo sociale improvvisamente decidono di avere bisogno del proprio spazio, fisico e mentale, e per i pochi giorni d’estate dei festival tagliano letteralmente i collegamenti con la loro vita abituale. Negli anni ’60 e sino ai primi anni ’90 i festival si trasformarono in eventi giganteschi, che potevano fruttare un bel malloppo in pochi giorni ma che spesso venivano organizzati in maniera follemente dilettantesca. Venivano percepiti come una sorta di bolla in cui senso di libertà e musica la facevano da padrone anche se non mancava la possibilità di godere marginalmente di sesso, alcol, droga, un po’ di violenza gratuita e fango, tanto fango. Nel corso degli anni ’90 il fenomeno si normalizzò, il senso di anarchia si stemperò fino a sparire lasciando più spazio ai soldi e al main stream. Fu come se ai festival fosse stato applicato lo stesso trattamento destinato, durante gli stessi anni, al tifo inglese negli stadi, anche se attraverso modalità meno dirette (e repressive) da parte del governo.
Una delle cose più interessanti del documentario è l’affermazione che almeno un britannico adulto su 10 avrebbe preso parte nel 2010 ad un festival musicale. Se ci si pensa è un dato incredibile, quasi 4 milioni di persone. Una parte di questi spettatori inoltre hanno dormito nelle tende, socializzato e si sono rilassati godendo appieno dell’atmosfera originaria dei festivals; la maggior parte si sono ascoltati solo i concerti. In entrambi i casi, però, la sensazione è quella di trovarsi di fronte ad un fenomeno che ormai è cementato nella cultura nazionale, quasi una tradizione. I padri andavano all’isola di Whight, i figli a Glastonbury.
Molto diversa è stata invece la sensazione che ho avuto dalla visione del secondo documentario dal titolo Best Before End, prodotto da Ottofilm nel 2013 per la regia di Charlotte Trigari. Tramite una serie di interviste agli organizzatori, il documentario cerca di raccontare il mondo festivaliero italiano. Quello che restituisce è una sensazione di precarietà e disillusione. Nonostante il lavoro e la passione dei ragazzi che si sbattono per mesi, il leit motiv delle interviste è “quest’anno è andata ma non sappiamo per quanto potrà durare”. Questa insicurezza è avvertibile sia nella fase di raccolta dei fondi necessari a far partire la macchina dell’organizzazione, sia nei rapporti con le amministrazioni comunali e la cittadinanza, che durante i festival spesso si rivolgono a vigili e polizia per mettere i bastoni tra le ruote alla manifestazione adducendo come motivi la presenza di musica ad alto volume, schiamazzi e fastidi vari. Le differenze con la Gran Bretagna sono evidentissime. Da noi i festival sono piccoli, spesso gratuiti e sopravvivono grazie al lavoro dei volontari, la musica è prettamente indie, di musicisti da classifica neanche l’ombra (giusto Caparezza). Gli organizzatori non si spiegano perchè un fenomeno che all’estero è fonte di guadagno e cultura da noi non è mai riuscito ad imporsi come una delle esperienze che un ragazzo italiano può/deve fare nell’arco di un estate e le sporadiche volte che c’è riuscito è stato grazie ai soldi di marche di birre o a grossi finanziamenti pubblici. La mia risposta è che fondamentalmente l’idea di festival non sia mai penetrata nell’animo degli italiani. La musica da noi è vissuta generalmente come una cosa che ti viene consegnata a casa tutta bella impacchettata piuttosto che qualcosa che ti vai a cercare, che sei disposto a scoprire ed a sperimentare. Detto questo, devo fare anche qualche critica a chi i festival li organizza e che non va oltre a un’idea abbastanza localistica dell’evento. I festival italiani non fanno rete, non si pubblicizzano a vicenda, spesso non riescono a pubblicizzarsi neanche fuori provincia. Non penso sia un atteggiamento dettato dall’idea di allontanare il grande pubblico ma piuttosto un accontentarsi del fatto che, a prescindere che il festival vada bene o male, loro anche per quell’anno ce l’hanno fatta: il festival è partito e quindi è riuscito. Certo il non voler fare il passo più lungo della gamba è sempre un buon proposito, ma castrarsi da soli non utilizzando per esempio i social media per tempo e in maniera massiva e intelligente è un vero peccato e lo dico da diretto interessato. Quando c’è stata la possibilità di abbinare le ferie e qualche giretto turistico con festival e concerti noi del blog non ci siamo mai tirati indietro. Livorno, Torino, Arezzo, Lucca. Città visitate grazie alla musica. Evito perciò di riportare le mie parole, per lo più blasfeme, quando ho saputo il giorno stesso del concerto che gli Eels il 17 luglio erano a Fiesole. Leggo blog, forum, twitter, facebook, leggo riviste, ascolto la radio, guardo la tv e del concerto non mi era giunta notizia fino a quel giorno. Sarà che faccio tutte queste cose sporadicamente, non in maniera assidua, ma mi sento un po’ preso per il culo. Tre giorni a Firenze e concerto degli Eels, sarebbe stato perfetto e invece ciccia. Quest’anno non ci sarebbe stato nessun viaggetto musicale a meno di un miracolo dell’ultimo minuto. Ma fortunatamente questo miracolo alla fine si è materializzato con le parvenze dinoccolate e pordenonewyorkesi del bassista dei Tre allegri ragazzi morti, Enrico Molteni. Molteni, che è anche il fondatore e gran visir della Tempesta Dischi, possiede il dono di apparire improvvisamente a qualsiasi concerto nel raggio di un centinaio di chilometri da Pordenone. Proprio come al concerto dei The War on Drugs per l’ultimo appuntamento di luglio per Sexto ‘nplugged, ancora presso l’abbazia di Sesto al Reghena. I War on Drugs sono degli ottimi musicisti, ben amalgamati, capitanati da Adam Granduciel. Tutto del concerto è ottimo, i musicisti non sbagliano niente e la voce di Granduciel è adatta alle canzoni, lunghe ballads che alla fine si allungano in psicadeliche schitarrate. Eppure dopo tre/quattro pezzi comincio un po’ ad annoiarmi, verso la fine tengo a fatica gli occhi aperti e ogni tanto la testa ciondola. Questa volta ringrazio il cielo che al Sexto i concerti si ascoltano seduti.
Gli organizzatori non si spiegano perchè un fenomeno che all’estero è fonte di guadagno e cultura da noi non è mai riuscito ad imporsi come una delle esperienze che un ragazzo italiano può/deve fare nell’arco di un estate e le sporadiche volte che c’è riuscito è stato grazie ai soldi di marche di birre o a grossi finanziamenti pubblici. La mia risposta è che fondamentalmente l’idea di festival non sia mai penetrata nell’animo degli italiani. La musica da noi è vissuta generalmente come una cosa che ti viene consegnata a casa tutta bella impacchettata piuttosto che qualcosa che ti vai a cercare, che sei disposto a scoprire ed a sperimentare. Detto questo, devo fare anche qualche critica a chi i festival li organizza e che non va oltre a un’idea abbastanza localistica dell’evento. I festival italiani non fanno rete, non si pubblicizzano a vicenda, spesso non riescono a pubblicizzarsi neanche fuori provincia. Non penso sia un atteggiamento dettato dall’idea di allontanare il grande pubblico ma piuttosto un accontentarsi del fatto che, a prescindere che il festival vada bene o male, loro anche per quell’anno ce l’hanno fatta: il festival è partito e quindi è riuscito. Certo il non voler fare il passo più lungo della gamba è sempre un buon proposito, ma castrarsi da soli non utilizzando per esempio i social media per tempo e in maniera massiva e intelligente è un vero peccato e lo dico da diretto interessato. Quando c’è stata la possibilità di abbinare le ferie e qualche giretto turistico con festival e concerti noi del blog non ci siamo mai tirati indietro. Livorno, Torino, Arezzo, Lucca. Città visitate grazie alla musica. Evito perciò di riportare le mie parole, per lo più blasfeme, quando ho saputo il giorno stesso del concerto che gli Eels il 17 luglio erano a Fiesole. Leggo blog, forum, twitter, facebook, leggo riviste, ascolto la radio, guardo la tv e del concerto non mi era giunta notizia fino a quel giorno. Sarà che faccio tutte queste cose sporadicamente, non in maniera assidua, ma mi sento un po’ preso per il culo. Tre giorni a Firenze e concerto degli Eels, sarebbe stato perfetto e invece ciccia. Quest’anno non ci sarebbe stato nessun viaggetto musicale a meno di un miracolo dell’ultimo minuto. Ma fortunatamente questo miracolo alla fine si è materializzato con le parvenze dinoccolate e pordenonewyorkesi del bassista dei Tre allegri ragazzi morti, Enrico Molteni. Molteni, che è anche il fondatore e gran visir della Tempesta Dischi, possiede il dono di apparire improvvisamente a qualsiasi concerto nel raggio di un centinaio di chilometri da Pordenone. Proprio come al concerto dei The War on Drugs per l’ultimo appuntamento di luglio per Sexto ‘nplugged, ancora presso l’abbazia di Sesto al Reghena. I War on Drugs sono degli ottimi musicisti, ben amalgamati, capitanati da Adam Granduciel. Tutto del concerto è ottimo, i musicisti non sbagliano niente e la voce di Granduciel è adatta alle canzoni, lunghe ballads che alla fine si allungano in psicadeliche schitarrate. Eppure dopo tre/quattro pezzi comincio un po’ ad annoiarmi, verso la fine tengo a fatica gli occhi aperti e ogni tanto la testa ciondola. Questa volta ringrazio il cielo che al Sexto i concerti si ascoltano seduti.
Uscendo avviene il miracolo molteniano: scorgo dei volantini, sicuramente lasciati dal nostro, che pubblicizzano l’edizione 2014 del concerto a cui partecipano gli artisti dell’etichetta e che si intitola La Tempesta, l’Emilia, la Luna. Il concerto si svolge nell’ambito dell’Arti Vive Festival di Soliera in provincia di Modena, una rassegna di teatro, musica e fotografia. Oltre alla Tempesta è previsto il concerto dei Fuck Buttons. Un attimo. I Fuck Buttons? Dobbiamo assolutamente andarci. Nel giro di qualche giorno ci organizziamo e partiamo. Tutta la combriccola è allogiata a Nonantola, città dall’imponente abbazia romanica. Da abbazia ad abbazia, è un segno.
A fare da spalla ai FB ci sono i DID, band torinese dalle ottime basi elettroniche su cui si inseriscono delle chitarre matematiche che mi ricordano i Foals di Antidotes o ritmiche africaneggianti alla Vampire Weekend. Putroppo un grande palco di una piazza non è il luogo più congeniale per la loro musica che ascolterei più volentieri in un piccolo club o ad una festa con falò sulla spiaggia. E la stessa sensazione ce l’ho ascoltando i Fuck Buttons: la location conta eccome.  Comunque il duo inglese non tradisce, con la loro elettronica che si sviluppa in strati geologici che si accumulano col passare dei secondi e che ti schiacciano fino a farti raggiungere uno sorta di trance. Non c’è niente da fare, ti viene da ascoltare chiudendo gli occhi e partendo con la mente per panorami frattali fatti di 0/1. Andrew Hung e Benjamin John Power scodellano i pezzi migliori e ogni volta ti spalmano di elettronica fino ad ipnotizzarti, fino a che qualche scossa tellurica di puro frastuono ti risveglia. Aspettavo di ascoltare live Olimpians e Surf Solar con la bava alla bocca e non sono rimasto deluso e tutto il concerto è stato perfetto. Posso finalmente depennare i Fuck Buttons dalla mia wish list.
Comunque il duo inglese non tradisce, con la loro elettronica che si sviluppa in strati geologici che si accumulano col passare dei secondi e che ti schiacciano fino a farti raggiungere uno sorta di trance. Non c’è niente da fare, ti viene da ascoltare chiudendo gli occhi e partendo con la mente per panorami frattali fatti di 0/1. Andrew Hung e Benjamin John Power scodellano i pezzi migliori e ogni volta ti spalmano di elettronica fino ad ipnotizzarti, fino a che qualche scossa tellurica di puro frastuono ti risveglia. Aspettavo di ascoltare live Olimpians e Surf Solar con la bava alla bocca e non sono rimasto deluso e tutto il concerto è stato perfetto. Posso finalmente depennare i Fuck Buttons dalla mia wish list.
Il giorno dopo non ho più nulla da chiedere a livello musicale e posso dedicarmi a fare il turista, visitando Nonantola e la sua abbazia, Modena e il suo duomo e i suoi musei chiusi per il terremoto. Ma a questo punto mentre, bagnato dalla pioggia, nell’unico bar di Modena aperto a luglio, assieme agli amici mangio una zeppola siciliana completamente ghiacciata e guardando ogni tanto il cielo, un po’ preoccupato per la Tempesta che sta arrivando, cedo volentieri il testimone all’alunno Proserpio perchè racconti il prosieguo di questa intensa estate musicale.
Prima puntata di “From abbey to abbey – Report musicale di mezza estate”




 Questi sentimenti, a cui in breve tempo si aggiunse il desiderio di ballare a ritmo di musiche più moderne rispetto alle melodie barocche di Purcell o alle marce per bande di J. P. Sousa, erano per lo più prerogativa di una precisa porzione della società inglese, quella dei giovani cittadini nati durante le ristrettezze del dopoguerra. I componenti di questo nuovo gruppo sociale improvvisamente decidono di avere bisogno del proprio spazio, fisico e mentale, e per i pochi giorni d’estate dei festival tagliano letteralmente i collegamenti con la loro vita abituale. Negli anni ’60 e sino ai primi anni ’90 i festival si trasformarono in eventi giganteschi, che potevano fruttare un bel malloppo in pochi giorni ma che spesso venivano organizzati in maniera follemente dilettantesca. Venivano percepiti come una sorta di bolla in cui senso di libertà e musica la facevano da padrone anche se non mancava la possibilità di godere marginalmente di sesso, alcol, droga, un po’ di violenza gratuita e fango, tanto fango. Nel corso degli anni ’90 il fenomeno si normalizzò, il senso di anarchia si stemperò fino a sparire lasciando più spazio ai soldi e al main stream. Fu come se ai festival fosse stato applicato lo stesso trattamento destinato, durante gli stessi anni, al tifo inglese negli stadi, anche se attraverso modalità meno dirette (e repressive) da parte del governo.
Questi sentimenti, a cui in breve tempo si aggiunse il desiderio di ballare a ritmo di musiche più moderne rispetto alle melodie barocche di Purcell o alle marce per bande di J. P. Sousa, erano per lo più prerogativa di una precisa porzione della società inglese, quella dei giovani cittadini nati durante le ristrettezze del dopoguerra. I componenti di questo nuovo gruppo sociale improvvisamente decidono di avere bisogno del proprio spazio, fisico e mentale, e per i pochi giorni d’estate dei festival tagliano letteralmente i collegamenti con la loro vita abituale. Negli anni ’60 e sino ai primi anni ’90 i festival si trasformarono in eventi giganteschi, che potevano fruttare un bel malloppo in pochi giorni ma che spesso venivano organizzati in maniera follemente dilettantesca. Venivano percepiti come una sorta di bolla in cui senso di libertà e musica la facevano da padrone anche se non mancava la possibilità di godere marginalmente di sesso, alcol, droga, un po’ di violenza gratuita e fango, tanto fango. Nel corso degli anni ’90 il fenomeno si normalizzò, il senso di anarchia si stemperò fino a sparire lasciando più spazio ai soldi e al main stream. Fu come se ai festival fosse stato applicato lo stesso trattamento destinato, durante gli stessi anni, al tifo inglese negli stadi, anche se attraverso modalità meno dirette (e repressive) da parte del governo. Gli organizzatori non si spiegano perchè un fenomeno che all’estero è fonte di guadagno e cultura da noi non è mai riuscito ad imporsi come una delle esperienze che un ragazzo italiano può/deve fare nell’arco di un estate e le sporadiche volte che c’è riuscito è stato grazie ai soldi di marche di birre o a grossi finanziamenti pubblici. La mia risposta è che fondamentalmente l’idea di festival non sia mai penetrata nell’animo degli italiani. La musica da noi è vissuta generalmente come una cosa che ti viene consegnata a casa tutta bella impacchettata piuttosto che qualcosa che ti vai a cercare, che sei disposto a scoprire ed a sperimentare. Detto questo, devo fare anche qualche critica a chi i festival li organizza e che non va oltre a un’idea abbastanza localistica dell’evento. I festival italiani non fanno rete, non si pubblicizzano a vicenda, spesso non riescono a pubblicizzarsi neanche fuori provincia. Non penso sia un atteggiamento dettato dall’idea di allontanare il grande pubblico ma piuttosto un accontentarsi del fatto che, a prescindere che il festival vada bene o male, loro anche per quell’anno ce l’hanno fatta: il festival è partito e quindi è riuscito. Certo il non voler fare il passo più lungo della gamba è sempre un buon proposito, ma castrarsi da soli non utilizzando per esempio i social media per tempo e in maniera massiva e intelligente è un vero peccato e lo dico da diretto interessato. Quando c’è stata la possibilità di abbinare le ferie e qualche giretto turistico con festival e concerti noi del blog non ci siamo mai tirati indietro. Livorno, Torino, Arezzo, Lucca. Città visitate grazie alla musica. Evito perciò di riportare le mie parole, per lo più blasfeme, quando ho saputo il giorno stesso del concerto che gli Eels il 17 luglio erano a Fiesole. Leggo blog, forum, twitter, facebook, leggo riviste, ascolto la radio, guardo la tv e del concerto non mi era giunta notizia fino a quel giorno. Sarà che faccio tutte queste cose sporadicamente, non in maniera assidua, ma mi sento un po’ preso per il culo. Tre giorni a Firenze e concerto degli Eels, sarebbe stato perfetto e invece ciccia. Quest’anno non ci sarebbe stato nessun viaggetto musicale a meno di un miracolo dell’ultimo minuto. Ma fortunatamente questo miracolo alla fine si è materializzato con le parvenze dinoccolate e pordenonewyorkesi del bassista dei Tre allegri ragazzi morti, Enrico Molteni. Molteni, che è anche il fondatore e gran visir della
Gli organizzatori non si spiegano perchè un fenomeno che all’estero è fonte di guadagno e cultura da noi non è mai riuscito ad imporsi come una delle esperienze che un ragazzo italiano può/deve fare nell’arco di un estate e le sporadiche volte che c’è riuscito è stato grazie ai soldi di marche di birre o a grossi finanziamenti pubblici. La mia risposta è che fondamentalmente l’idea di festival non sia mai penetrata nell’animo degli italiani. La musica da noi è vissuta generalmente come una cosa che ti viene consegnata a casa tutta bella impacchettata piuttosto che qualcosa che ti vai a cercare, che sei disposto a scoprire ed a sperimentare. Detto questo, devo fare anche qualche critica a chi i festival li organizza e che non va oltre a un’idea abbastanza localistica dell’evento. I festival italiani non fanno rete, non si pubblicizzano a vicenda, spesso non riescono a pubblicizzarsi neanche fuori provincia. Non penso sia un atteggiamento dettato dall’idea di allontanare il grande pubblico ma piuttosto un accontentarsi del fatto che, a prescindere che il festival vada bene o male, loro anche per quell’anno ce l’hanno fatta: il festival è partito e quindi è riuscito. Certo il non voler fare il passo più lungo della gamba è sempre un buon proposito, ma castrarsi da soli non utilizzando per esempio i social media per tempo e in maniera massiva e intelligente è un vero peccato e lo dico da diretto interessato. Quando c’è stata la possibilità di abbinare le ferie e qualche giretto turistico con festival e concerti noi del blog non ci siamo mai tirati indietro. Livorno, Torino, Arezzo, Lucca. Città visitate grazie alla musica. Evito perciò di riportare le mie parole, per lo più blasfeme, quando ho saputo il giorno stesso del concerto che gli Eels il 17 luglio erano a Fiesole. Leggo blog, forum, twitter, facebook, leggo riviste, ascolto la radio, guardo la tv e del concerto non mi era giunta notizia fino a quel giorno. Sarà che faccio tutte queste cose sporadicamente, non in maniera assidua, ma mi sento un po’ preso per il culo. Tre giorni a Firenze e concerto degli Eels, sarebbe stato perfetto e invece ciccia. Quest’anno non ci sarebbe stato nessun viaggetto musicale a meno di un miracolo dell’ultimo minuto. Ma fortunatamente questo miracolo alla fine si è materializzato con le parvenze dinoccolate e pordenonewyorkesi del bassista dei Tre allegri ragazzi morti, Enrico Molteni. Molteni, che è anche il fondatore e gran visir della  Comunque il duo inglese non tradisce, con la loro elettronica che si sviluppa in strati geologici che si accumulano col passare dei secondi e che ti schiacciano fino a farti raggiungere uno sorta di trance. Non c’è niente da fare, ti viene da ascoltare chiudendo gli occhi e partendo con la mente per panorami frattali fatti di 0/1. Andrew Hung e Benjamin John Power scodellano i pezzi migliori e ogni volta ti spalmano di elettronica fino ad ipnotizzarti, fino a che qualche scossa tellurica di puro frastuono ti risveglia. Aspettavo di ascoltare live Olimpians e Surf Solar con la bava alla bocca e non sono rimasto deluso e tutto il concerto è stato perfetto. Posso finalmente depennare i Fuck Buttons dalla mia wish list.
Comunque il duo inglese non tradisce, con la loro elettronica che si sviluppa in strati geologici che si accumulano col passare dei secondi e che ti schiacciano fino a farti raggiungere uno sorta di trance. Non c’è niente da fare, ti viene da ascoltare chiudendo gli occhi e partendo con la mente per panorami frattali fatti di 0/1. Andrew Hung e Benjamin John Power scodellano i pezzi migliori e ogni volta ti spalmano di elettronica fino ad ipnotizzarti, fino a che qualche scossa tellurica di puro frastuono ti risveglia. Aspettavo di ascoltare live Olimpians e Surf Solar con la bava alla bocca e non sono rimasto deluso e tutto il concerto è stato perfetto. Posso finalmente depennare i Fuck Buttons dalla mia wish list.